Prima di immergermi nelle fredde acque di questa storia, vi chiedo un gesto caloroso e umano. Iscrivetevi a questo canale. È l’unico modo per rompere il ghiaccio dell’indifferenza che avvolge il passato. Attivate le notifiche in modo che ognuna di esse sia come una candela accesa in ricordo delle vittime.

E fateci sapere nei commenti da dove state ascoltando.
Fa caldo nel tuo soggiorno a Parigi, nel tuo ufficio a Bruxelles o da qualche altra parte? Fai attenzione alla temperatura nella tua stanza, perché stiamo per trasferirci in un luogo dove non c’è riscaldamento. La storia che stai per ascoltare si basa su cartelle cliniche ritrovate dopo la guerra.
Questa è la storia di come la medicina, concepita per guarire, divenne lo strumento di tortura più sofisticato del regime. Fate un respiro profondo e preparatevi al freddo pungente. Per favore, non voglio entrare in acqua. Parte 1: Il nuotatore di Ravensbrück.
Era una mattina di gennaio del 1943 nel campo di concentramento di Ravensbrück. La temperatura esterna era di -1°C.
Il cielo era di un bianco brillante, una cupola di brina circondava l’accampamento come una cupola di vetro. La ventiquattrenne Lena rimase eretta durante l’appello. A differenza delle altre donne che si rimpicciolivano, si accasciavano e diventavano trasparenti al vento impetuoso, Lena rimase salda. Era una questione di disciplina.
Prima della guerra ad Annecy, era stata una campionessa di nuoto.
Conosceva bene l’acqua. Conosceva il freddo dei laghi di montagna al mattino presto. Aveva allenato il suo corpo a domare i brividi, a trasformare il dolore indotto dal calore in energia propulsiva. Pensava che questa flessibilità fosse la sua arma migliore per sopravvivere lì. Ma si sbagliava.
La sua flessibilità era una condanna a morte. Alla fine della strada, un gruppo di agenti si avvicinò.
C’erano guardie delle forze speciali di sicurezza con i loro cani, selvaggi, ululanti. Ma c’era anche un uomo diverso. Indossava una lunga giacca di pelle nera, un cappello a tesa alta e sotto il braccio, non una frusta, ma una morbida borsa di pelle.

Il dottor Sigmund Rascher, un nome storico o ispirato a personaggi reali, non considerava i prigionieri nemici, ma riserve. Cercava materie prime di alta qualità. Si fermò davanti alla fila di Lena. Non urlò, ma fece un gesto con la mano, e calò un silenzio pesante e terrificante.
Le si avvicinò. Vide le sue spalle larghe, come quelle di una nuotatrice, ancora visibili nonostante la magrezza.
Vide le sue gambe lunghe e muscolose, nonostante la fame. Vide il colore della sua pelle, ancora rosa, segno di un’eccezionale circolazione sanguigna. Lesse sulla sua uniforme: “Prigioniera numero 7422”. “Da dove viene?” Lena esitò. Quelle parole erano pericolose. Il silenzio era mortale. “Francia, dottoressa”.
“Ansi, atletico, un nuotatore, Dottore.” Un sorriso debole, quasi impercettibile, sfiorò le labbra del dottore. Non era un sorriso sadico, ma piuttosto il sorriso di un ingegnere che aveva appena trovato il pezzo mancante della sua macchina. “Eccellente, ne avremo bisogno. La sua capacità polmonare dev’essere eccellente.”
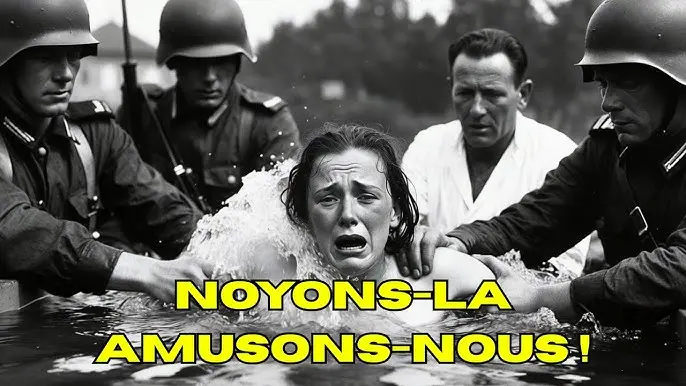
“Anche la resistenza vascolare.” Si rivolse alla guardia. “Questo e gli altri tre che hai notato. Portali nel reparto sperimentale.” Lena sentì subito un brivido, molto più intenso dei brividi invernali che di solito la percorrevano. Il reparto sperimentale. Tutti ne parlavano a bassa voce.
Si diceva che i medici stessero cercando una cura per i soldati in prima linea.
Si diceva che il cibo lì fosse migliore, ma si diceva anche che chiunque entrasse non uscisse mai, o ne uscisse cenere. “Muoviti!” urlò la guardia, spingendola con il calcio del fucile. Lena si mosse.
Lasciò la fila, lasciandosi alle spalle le sue compagne di cella, che la guardarono con un misto di pietà e sollievo. “Non mi muoverò, non oggi, non mi muoverò.” Attraversarono il campo.
La neve scricchiolava sotto i loro zoccoli di legno. Raggiunsero un edificio di mattoni rossi, circondato da una doppia recinzione di filo spinato. Le finestre erano alte, dipinte di un bianco opaco. Dall’esterno non si vedeva nulla. Dentro, lo shock fu brutale. Faceva caldo.
Un caldo secco e intenso, come quello del riscaldamento centralizzato.
Profumava di etere, caffè appena fatto e tabacco biondo. Per un attimo, Lena pensò che fosse un miracolo. Forse avevano bisogno di infermiere. Forse si sarebbe semplicemente pulita. La condussero in una sala d’attesa con piastrelle bianche.
Un’infermiera le ordinò con voce cupa: “Togliti i vestiti! Piegali sulla panca e aspetta!”. Lena obbedì. Si tolse la giacca a righe, le calze strappate e gli zoccoli.
Si ritrovò nuda, tremante nonostante il caldo. Si guardò il corpo. Era magro. Le costole erano sporgenti, ma era ancora forte. Strinse i pugni. “Sono una nuotatrice”, ripeté tra sé e sé come un mantra. “L’acqua è un elemento fondamentale. Posso affrontare qualsiasi cosa.” La porta sul retro si aprì.
Apparve il dottor Rasher. Si era tolto il cappotto di pelle, rivelandone uno bianco immacolato sotto.
Teneva un cronometro d’argento in una mano e una penna nell’altra. “Ingresso numero 7422.” Lena entrò da sola.
La stanza era immensa, con pareti piastrellate di bianco che si estendevano fino al soffitto. La luce fluorescente era intensa e priva di ombre. Al centro della stanza non c’era un tavolo operatorio, ma una vasca da bagno.
Era una grande e profonda vasca di metallo, simile a quelle usate nei bagni industriali.
Sopra di lui, una serie di carrucole e paranchi pendevano dal soffitto, e tutt’intorno, sul pavimento piastrellato, c’erano blocchi di ghiaccio. Enormi blocchi traslucidi, ricavati dal vicino laghetto. Lena capì. Le si gelò il sangue. Guardò l’acqua nella vasca. Era buia e immobile.
Schegge di ghiaccio galleggiavano, sbattendo l’una contro l’altra con un suono minaccioso.
Il Dott. Rasher ha iniziato il suo discorso con un tono da conferenza, come se stesse tenendo una lezione universitaria: “L’aeronautica militare tedesca ha un problema. I nostri piloti vengono abbattuti sopra il Mare del Nord. La temperatura dell’acqua è tra zero e tre gradi Celsius.
Muoiono di ipotermia nel giro di pochi minuti”.
Stiamo perdendo cari uomini, non a causa dei proiettili, ma a causa del freddo.” Si avvicinò alla vasca e immerse un termometro nell’acqua. “Dobbiamo sapere con precisione per quanto tempo il corpo umano può resistere al freddo. Dobbiamo comprendere il processo di congelamento per poterlo combattere meglio.”
Dobbiamo sapere in quale minuto il cuore si ferma e in quale secondo il cervello smette di funzionare.” Prese il termometro e lo mostrò a Lena. “Mezzo grado. Ottimo.”
Lena fece un passo indietro, nuda, vulnerabile. “No, non sono un pilota”, sussurrò. “Sono una donna”. “Esatto”, la interruppe il medico. “Le donne hanno uno strato di grasso sottocutaneo diverso. A volte è più sodo. È un fattore importante nelle mie statistiche”. Annuì.
Due assistenti, uomini robusti con grembiuli di gomma, emersero da dietro la porta. Non dissero una parola.
Afferrarono Lena per le braccia. Lei si divincolò. La reazione di un animale intrappolato. Graffiò il muso di uno di loro. Cercò di mordere. “No, lasciatemi andare! Aiutatemi!” La sua voce echeggiò sulle fredde piastrelle, amplificata dal tubare dei piccioni, ma nessuno si fece avanti.
Il medico scrisse semplicemente sul suo taccuino: “Paziente aggressiva, buon tono muscolare, alto livello di adrenalina”.
I due uomini la sollevarono da terra. Lei scalciò in aria. La condussero alla vasca da bagno. Il freddo che saliva dall’acqua la avvolse come un vapore invisibile. Il medico disse con calma: “Legatele i polsi e mettetele il giogo. Non voglio che galleggi da sola”. Lena vide lo strumento.
Era una forcella di legno, un solido giogo progettato per stringere il collo e impedire alla vittima di stare in piedi.
Gridò: “Per favore, farò qualsiasi cosa. Lavorerò. Prenderò i calcoli. Non questo, non il raffreddore”. Il medico avviò il cronometro. Clac.
“L’esperimento inizia ora. Annegatela.” Gli assistenti la liberarono. Lena cadde in acqua. L’impatto non fu liquido, fu solido. Fu come cadere sul cemento. L’acqua a zero gradi non bagna il corpo, lo colpisce, perforando la pelle come un milione di aghi contemporaneamente.
Lena aprì la bocca per urlare, ma l’aria le fu espulsa dai polmoni a causa della violenta contrazione della gabbia toracica. Era nel ghiaccio e gli uomini, con i loro forconi di legno, le premevano sulle spalle per tenerla immersa. L’acqua non la bruciava più; la pungeva.
Dal primo secondo in cui rimase immersa, il corpo di Lena entrò in uno stato di forte shock termico.
Era come se un gigantesco pugno di ghiaccio e acciaio le avesse schiacciato la cassa toracica. Aprì la bocca per inspirare, ma i suoi muscoli intercostali, paralizzati dal freddo pungente, si rifiutarono di reagire. Stava soffocando.
Lì, in quella vasca bianca, con la testa sollevata dall’acqua da un giogo di legno che le sfregava contro il collo, stava sprofondando nell’aria aperta.
“Nota: spasmo respiratorio immediato, cianosi delle labbra che compare entro 0,30 secondi. Il paziente è in preda al panico; è un caso classico”, disse il Dott. Rasher con voce calma, quasi annoiata. Era seduto su un seggiolone, a meno di un metro dal bordo del bacino.
Aveva una gamba accavallata sotto il camice bianco.
Nella mano destra non teneva uno strumento medico, ma una raffinata tazza di porcellana, da cui si levava il vapore. L’aroma forte e caldo del caffè appena macinato riempiva l’aria, mescolandosi al sapore metallico del ghiaccio. Il contrasto era netto.
Lui, circondato da vapore caldo, stava bevendo la vita; lei, annegando nella morte liquida, sentiva il sangue rallentare. Lena cercò di reagire. Il suo istinto natatorio, affinato da anni di allenamento nelle fredde acque delle Alpi, stava cercando di riconquistare il comando.
La sua mente urlava: “Muoviti! Se ti muovi, sentirai il caldo”. Ma il freddo della vasca da bagno era innaturale. Iceberg le fluttuavano intorno, come minuscoli iceberg, che le sferzavano la pelle nuda a ogni movimento. Le sue braccia, legate ai polsi, erano immobili.
Le sue gambe si agitavano freneticamente nell’acqua, schizzando sulle piastrelle pulite.
Ma l’energia che stava spendendo non faceva che accelerare la perdita di calore. Un minuto e sessanta secondi. Il dolore cambiò. All’inizio, fu come un attacco alla pelle, la sensazione di un milione di aghi che la pungevano. Ora, il freddo penetrava più a fondo.
Cercava le ossa, cercava il midollo. Lena sentì le articolazioni irrigidirsi come se le stessero versando del cemento a presa rapida nelle ginocchia e nei gomiti.
Guardò il dottore. Non riusciva a parlare. Batteva i denti così forte che aveva paura di mordersi la lingua, ma i suoi occhi urlavano: “Perché? Sono un essere umano. Mi chiamo Lena. Ho una madre. Ho una vita”. Gli occhi del dottor Rasher incontrarono i suoi.
Bevve un sorso di caffè. Non sorrise. Non mostrò rabbia. Mostrò qualcosa di peggio: totale indifferenza.
Guardò Lena come un falegname guarda una tavola di legno, valutandone la resistenza alla flessione. “Temperatura corporea stimata 35 gradi”, dettò al suo assistente. “I brividi sono al culmine. Questa è la fase di attacco o fuga.
Il corpo sta bruciando le ultime riserve di glucosio rimaste per mantenere la temperatura interna. Guarda la pelle: è screziata. Questa è vasocostrizione periferica.”
Il sangue abbandona la superficie per proteggere gli organi vitali. Interessante.” Ne parlava come se si trattasse di una macchina rotta. Cinque minuti. Le contrazioni cessarono bruscamente. A un osservatore esterno, sarebbe potuto sembrare che il dolore si fosse attenuato.
Lena non si muoveva più, le sue gambe non si agitavano più nell’acqua. Era appesa immobile nella gabbia di legno.
Ma dentro di me, era la fine del mondo. Il tremore cessò; fu il momento in cui il corpo si arrese.
La corrente elettrica andò via. La caldaia si ruppe. Lena iniziò a perdere conoscenza, non fisicamente, ma mentalmente. Il dolore lancinante dei primi minuti svanì, sostituito da una strana sensazione di intorpidimento, quasi leggera, pesante. Non era più a Ravensbrück. Le piastrelle bianche erano sparite.
Il volto freddo del medico era scomparso. Era di nuovo ad Annecy. Era l’estate del 1939.
Era sul molo di legno in riva al lago. Il sole era alto nel cielo, cocente. L’acqua luccicava come un campo di diamanti blu. Sua sorella Mary era lì. Rideva. Le porse un asciugamano giallo caldo appena sfornato. Mary disse: “Dai, Lena, esci dall’acqua. Fa così caldo qui dentro”.
“Vieni a scaldarti.” Lena sorrise nella vasca ghiacciata. Le sue labbra blu si arricciarono in un cipiglio orribile e terrificante. “Arrivo, Mary!” sussurrò. “Arrivo! È caldo e accogliente.” Il dottor Rasher si sporse in avanti preoccupato. “Allucinazioni. Stiamo entrando nella fase critica. Ipotermia moderata, molto probabilmente zero gradi Celsius.”
Il cervello ha iniziato a funzionare male a causa della mancanza di ossigeno e del metabolismo rallentato. “Pensa di sentire caldo. Sono brividi paradossali.” Fece un gesto all’assistente, dicendo: “Spingi altro ghiaccio verso il cuore.”
“Voglio vedere se un impatto diretto causerà l’arresto cardiaco immediato o graduale.” L’assistente, un uomo enorme con le braccia rosse, prese un’asta di metallo e spinse un grosso blocco di ghiaccio direttamente sul petto di Lena. Il contatto con la zona del cuore avrebbe dovuto ucciderla. Lena sussultò.
Il sogno di Ansie si infranse come uno specchio.
La verità tornò, dura e implacabile. Il freddo non era un asciugamano caldo; era un pugnale. Si rese conto di non riuscire a sentire né i piedi né le mani. Non era altro che una testa fluttuante, una coscienza intrappolata in un cadavere congelato.
Il suo cuore batteva molto lentamente, in sillabe spezzate.
Ogni battito cardiaco era una lotta tremenda, uno sforzo doloroso per spingere il sangue, ormai denso come fango, attraverso le vene ristrette. Guardai il medico un’ultima volta. Batté la penna con impazienza sul foglio. “Dieci minuti!” annunciò. “Una resistenza superiore alla media.
La maggior parte degli uomini perde conoscenza entro sette minuti.”
“Il grasso sottocutaneo nelle donne funge da isolante.” Si alzò e posò la tazza di caffè vuota. “Okay, passiamo al passo successivo. Portatela fuori!” Lena pensava che fosse finita, che l’avrebbero asciugata, riscaldata e riportata al campo. Era ingenua. L’esperimento era appena iniziato.
L’obiettivo non era semplicemente scoprire come si congela il corpo.
L’obiettivo era scoprire come si scioglie il ghiaccio. I metodi di riscaldamento del dottor Rasher erano brutali quanto quelli di congelamento. Gli inservienti le slegarono i legacci. Poi sollevarono il corpo senza vita di Lena dall’acqua. Era rigida, bluastra e dura come il legno.
La gettarono su una barella con le ruote.
Rasher ordinò: “Stanza 2! Preparate le lampade”. Lena non poteva muoversi, ma riusciva ancora a sentire. Sentì le ruote sul pavimento piastrellato. Sentì il proprio respiro, un debole sibilo. Si sentì svanire. Il sonno bianco, quel dolce sonno ipotermico, la chiamava.
Tutto quello che doveva fare era chiudere gli occhi, arrendersi e raggiungere Mary sul marciapiede. Ma una voce interiore, affinata da anni di corsa contro il tempo, le sussurrò: “No, non ancora. Se ti addormenti, morirai. Resta sveglia. Resta arrabbiata”.
Concentrò tutta la sua forza di volontà su un punto, la punta del mignolo sinistro.
Cercò di spostarlo. Solo di un millimetro. Era impossibile. La connessione tra cervello e muscoli era stata interrotta. La trascinarono in un’altra stanza, più buia. Al centro, un letto circondato da strane strutture metalliche, all’interno delle quali c’erano enormi lampade. “Spostatela sul letto”, ordinò l’assistente. La girarono.
Il suo corpo sbatté contro il materasso con un suono soffocato e pesante, come un sacco di carne congelata. Entrò il dottor Rasher. Si aggiustò gli occhiali.
“Primo metodo di riscaldamento: calore radiante intenso. Accendeteli.” Non si trattava di coperte calde; erano scatole riscaldanti, gabbie rivestite di potenti lampade industriali progettate per riscaldare il metallo, non la carne umana. L’assistente premette un pulsante. Dodici lampade da 1.000 watt si accesero simultaneamente sopra e intorno a Lena.
La luce era accecante, il calore…
Il calore non era delicato; era esplosivo. Il passaggio dal gelo al calore torrido in un solo secondo causò uno shock termico inverso, ancora più violento del primo. Lena, semi-incosciente, inarcò la schiena sul letto, formando un arco perfetto. Urlò.
Questa volta, il suono uscì, un grido rauco e spezzato, come ghiaccio che si rompe sotto una fiamma.
La sua pelle congelata cominciò a bruciare sotto le lampade, mentre le sue viscere rimanevano congelate. Era l’Inferno di Dante: essere bruciati vivi e congelati vivi contemporaneamente. Rasher osservò la reazione convulsa: “Interessante. Lo shock termico risveglia il sistema nervoso.”
Ma il cuore sopravviverà? Questo è il problema.” Si avvicinò, appoggiando uno stetoscopio freddo sul suo petto in fiamme. “Dai, mia cara”, le sussurrò all’orecchio. “Nuota. Nuota, riaffiora o affonda come una pietra!” Lena aprì gli occhi. Non vedeva altro che bianco.
La luce delle lampade le aveva bruciato la retina.
Sentì il cuore battere rapidamente, in modo irregolare, come un uccello intrappolato in una gabbia in fiamme. Era fibrillazione, lo stadio finale prima dell’arresto cardiaco.
In quella luce accecante, capì che il dottore non stava cercando di salvarla; stava giocando con lei, giocando con il suo destino. Voleva vedere quante volte avrebbe potuto ucciderla e riportarla in vita prima che soccombesse definitivamente.
Era stato l’odore a risvegliare Lena, ancor prima del dolore: il tanfo acre e nauseabondo della carne bruciata.
Le ci vollero alcuni secondi, in preda all’agonia, per rendersi conto che quella carne era la sua. Le dodici lampade, ciascuna da mille watt, avevano fatto il loro lavoro: ne avevano riscaldato la superficie.
La pelle del suo ventre e delle sue cosce, che pochi minuti prima era bianca e screziata dal freddo, ora era di un rosso vivo, ricoperta di vesciche. Stava letteralmente fumando sotto l’intensa radiazione.
Ma dentro, il freddo regnava ancora. Era una tortura fisica insopportabile. I suoi nervi periferici urlavano, inviando intensi segnali di bruciore al cervello, mentre i suoi organi vitali – cuore, fegato e polmoni – rimanevano intrappolati in un gelido interno. Il dottor Rasher premette il pulsante.
Tornò l’oscurità, interrotta solo da una luce intensa proveniente dal corridoio. Rasher si avvicinò e sollevò la palpebra di Lena con il pollice. “La pupilla sta rispondendo, ma lentamente”, notò. “La temperatura rettale è di 33 gradi. Il metodo della lampada è parzialmente inefficace.
Brucia l’epidermide prima di riscaldare la polpa.”
“Non è efficace per rianimare rapidamente un pilota.” La testa di Lena premette contro il cuscino duro. Ansimava, ogni respiro era una lotta. Il suo petto si alzava e si abbassava in modo irregolare, a un ritmo irregolare. “Bene”, disse Rasher, rivolgendosi ai suoi assistenti. “Procedete con il protocollo C.
Irrigazione interna.” Lena sentì la parola irrigazione.
Nella sua mente, da nuotatrice, la parola evocava canali, acqua dolce e vita. Ma qui, le parole avevano un doppio significato.
Il medico ordinò: “Portate l’attrezzatura per le analisi e l’acqua bollente”. Lena cercò di liberarsi, ma i suoi arti erano ancora paralizzati dal freddo e dal colpo di calore. Era come una bambola senza vita.
Vide l’assistente avvicinarsi, con in mano un grosso tubo di gomma rossa e un imbuto smaltato. “Aprile la bocca”. L’assistente afferrò il naso di Lena. Istintivamente, Lena aprì la bocca, ansimando.
Immediatamente, le fu inserito un dilatatore metallico, comprimendole le mascelle. Non riusciva più a chiudere la bocca. Non riusciva più a mordere. Era un tunnel aperto. Il tubo fu inserito con forza.
Le graffiò la lingua e le colpì la gola, provocandole un forte riflesso faringeo, ma l’assistente premette con decisione.
La gomma le scivolò lungo l’esofago, si aprì la strada, le trafisse la gola e le penetrò in profondità nello stomaco. Lena stava soffocando, le lacrime le rigavano le tempie, mescolandosi al sudore freddo. “Ragazzo.” L’acqua calda le scorreva dolcemente all’inizio.
Se un bagno ghiacciato era stato uno shock, l’acqua fredda a 15 gradi nel suo stomaco era come un’eruzione vulcanica.
Lena sentì il calore diffondersi nel suo corpo, non un calore lieve, ma una sensazione bruciante e bruciante. Era come ingoiare piombo fuso. Il suo stomaco, quell’organo sensibile, si contrasse violentemente attorno al liquido bollente, ma non riuscì a espellerlo a causa del tubo.
Il calore si diffuse immediatamente agli organi circostanti: il fegato, la milza e il plesso solare. Il contrasto di temperatura era insopportabile.
Il suo corpo era un campo di battaglia dove fuoco e ghiaccio si scontravano senza pietà. Dai suoi pori sembrava sprigionarsi vapore.
“Il suo polso sta aumentando”, annunciò l’assistente che le teneva il cuore. “120 battiti, 130.” “Continua così”, disse Rasher, con gli occhi fissi sul cronometro. “Dobbiamo forzare il cuore a battere di nuovo. È meccanica dei fluidi, niente di più.” Lena era in preda alle convulsioni sul tavolo operatorio.
La schiena si inarcava, i talloni battevano contro il metallo. Era l’orribile danza della rianimazione forzata.
Non urlò – il tubo glielo impedì – ma emise un gorgoglio straziante, come un animale che sta annegando. Sentì il calore salire al cuore. Quando il sangue caldo dallo stomaco raggiunse l’atrio destro, il suo cuore in preda al panico perse un battito. Poi due.
Per tre secondi, Lena stava morendo. Buio pesto, nessun dolore, nessun freddo, solo silenzio.
Poi una brutale scossa elettrica naturale riavviò la macchina. Clang! Un colpo di martello al petto. La vita tornò e, con essa, il dolore si intensificò dieci volte. “Interrompete l’irrigazione!” ordinò Rasher. “Rimuovete il tubo.” L’assistente strappò violentemente il tubo. Lena vomitò immediatamente.
Una miscela di acqua calda e bile le schizzò sul petto, che era stato ustionato dalle lampade.
Tossì, sputò e respirò affannosamente e con voce roca. Era viva, calda, ma tremante. Rasher si avvicinò, soddisfatto. Le posò una mano sulla fronte. “La temperatura stimata è di 36 gradi. La paziente è tornata alla normalità in meno di 20 minuti. È un record.
La lavanda gastrica è forte, ma efficace.” Si asciugò la mano sulla vestaglia.
“Vestitela e riportatela in sala operatoria. Mi servirà domani per il test di confronto. Valuteremo la sua resistenza al freddo secco all’aperto.”
I servi la vestirono con i suoi stracci bagnati. Non furono gentili, ma non la picchiarono. Avevano una sorta di paura superstiziosa di quella cosa che si rifiutava di morire. La trascinarono fuori. Lo shock del freddo pungente esterno, -18 gradi Celsius, la fece rabbrividire di nuovo.
Ma non erano gli stessi brividi; era paura.
La gettarono nella neve davanti al suo cottage. Lena rimase lì per un attimo, nel fango bianco. Le bruciava lo stomaco, la pelle, i muscoli le dolevano. Guardò il cielo grigio sopra Ravensbrook. Era sopravvissuta al ghiaccio, era sopravvissuta al fuoco.
Ma sapeva che qualcosa dentro di lei era ancora sul fondo dello stagno.
Lena Ansi, la nuotatrice baciata dal sole, era morta. Quella che lottava per emergere dalla neve era una nuova creatura, una creatura fatta di dolore e odio. Una donna le si avvicinò. Era russa, una prigioniera di guerra. Aiutò Lena… a camminare.
La donna russa sussurrò stupita: “Ti hanno riportata indietro? Nessuno torna mai dall’unità sperimentale”. Lena la guardò.
I suoi occhi erano vuoti, come due buchi neri. “Non tornerò indietro”, disse con una voce che sembrava lo scricchiolio del ghiaccio.
“Sono ancora lì.” Non sapeva che la parte peggiore non era l’esperienza in sé, ma gli effetti collaterali: danni ai reni, bruciore ai nervi e una costante sensazione di freddo che non la lasciava nemmeno in piena estate.
Ma per ora, camminava passo dopo passo verso il letto infestato dai pidocchi, perché finché camminava, il dottor Rasher non aveva vinto completamente. La notte in caserma era stata peggio del bagno. Nel bagno, il freddo era un nemico esterno, un attacco diretto.
A letto, il freddo era dentro di lei.
Proveniva dalle sue ossa, dal suo stomaco ustionato dall’acqua bollente, dal suo cuore che batteva con un ritmo staccato e irregolare. Lena non riusciva a dormire; non ci riusciva. La sua pelle, bruciata dalle lampade, sfregava contro la paglia sporca del letto.
Ogni movimento le lacerava la carne e provocava un gemito. Era una ferita aperta.
Accanto a lei, la prigioniera russa, la donna che l’aveva trovata nella neve, la stava osservando. Il suo nome era Katya.
Perse i denti e i capelli, ma una cosa rimase: il calore dell’animale. Katya si aggrappò alla schiena sanguinante di Lena. Non aveva paura dell’odore della carne bruciata. Non aveva paura della morte in agguato lì vicino.
Lui sussurrò in russo, una lingua che Lena non capiva, ma intuì la sua intenzione: “Prendilo! Prendi il mio calore, rubamelo. Ne ho abbastanza per due.” Lena pianse in silenzio.
Quel contatto umano, quella pelle contro la sua, era più doloroso del ghiaccio. Le ricordava che era ancora viva, che provava ancora dei sentimenti. E provare significava soffrire. Il mattino arrivò troppo in fretta. Un mattino grigio metallico. La chiamata, i cani, lui. Il dottor Rasher entrò nella caserma.
Era in ordine, appena rasato e profumava di colonia.
Stava cercando il suo giocattolo. Si aspettava di trovare un cadavere rigido a causa della febbre o di un arresto cardiaco durante la notte. Quando vide Lena seduta sul bordo del letto, tremante ma dritta, i suoi occhi si spalancarono leggermente dietro gli occhiali con la montatura dorata. “Incredibile!” sussurrò.
“La resilienza cellulare è incredibile.” Fece un gesto alla guardia. “Portala fuori.”
“Non in sala operatoria questa volta, portatela fuori.” “Passiamo alla fase due. Raffreddamento a secco.” Lena non oppose resistenza. Non aveva più la forza di urlare o mordere. Si alzò, lasciando Katya indietro. Camminò meccanicamente verso la porta. Quella notte aveva capito qualcosa. La paura prosciuga le energie.
La speranza prosciuga le energie. Per sopravvivere, non devi avere né speranza né paura. Devi isolarti dentro di te. La portarono in un cortile racchiuso da mura di mattoni alte tre metri. Non c’era vento, solo aria immobile e gelida.
Il termometro sul muro segnava meno venti gradi. “Toglietele i vestiti”, ordinò Rasher. Tolsero gli stracci. Il freddo le bruciò all’istante le ustioni, lenendo il fuoco nella pelle e riaccendendo il dolore nelle ossa. “Fatela sedere lì nella neve”. Non c’era una sedia, solo il pavimento bianco. Lena si sedette.
Tirò le gambe al petto e si strinse le braccia sottili intorno alle ginocchia, assumendo la posizione fetale, la posizione di un bambino che aspetta la nascita o di un vecchio che aspetta la morte. Il medico, seduto su una sedia pieghevole, avvolto nella pelliccia, disse: “Non si muova.
Se si muove, lavi la donna con acqua fredda”. Lena non si mosse. Passò un’ora, poi due. Il freddo secco è diverso dall’acqua.
È più lento e insidioso. Inizia dalle estremità. Lena vide le dita dei suoi piedi diventare bianche, poi grigie. Non le sentiva più. Era come se parti del suo corpo venissero cancellate. I suoi piedi erano spariti, e anche le sue mani erano sparite.
Rasher annotò i suoi appunti mentre sorseggiava tè caldo dal thermos. Individuò con precisione l’ora in cui era iniziato il congelamento, la necrosi dei tessuti. “Alle 2:10 precise del mattino, la paziente smise di tremare. Entrò in uno stato di letargia”. Fu allora che avvenne la trasformazione.
Lena, avvolta nella neve, chiuse gli occhi. Non cercò di ricordare Ansie o il calore. Tutt’altro.
Accolse con favore il freddo. Immaginò di non essere più carne e ossa. Era fatta di marmo. Una statua di pietra in un giardino d’inverno. La pietra non sente dolore. La pietra non piange. La pietra dura per sempre. Il suo battito cardiaco rallentò. Cinque battiti al minuto.
Entrò in uno stato di immobilità, sospesa tra la vita e la morte.
Inattività forzata, uno stato che gli yogi conoscevano, ma Lena lo stava scoprendo attraverso la pura agonia. Il dottor Rasher si avvicinò. Era agitato. Secondo i suoi calcoli, avrebbe dovuto perdere conoscenza 30 minuti prima. La spinse con la punta dello stivale.
Cadde su un fianco, rigida come una roccia, come una statua rovesciata. Non mostrò alcuna reazione. I suoi occhi erano aperti, vitrei, fissi nel vuoto.
“È morta?” chiese l’assistente. Rasher posò il dito sulla carotide di Lena. Attese a lungo. “No”, sussurrò. “C’è un debole battito, quasi invisibile, ma c’è. È impossibile. Impossibile dal punto di vista medico.” Guardò la donna nuda, ustionata, congelata, distrutta che si rifiutava ostinatamente di lasciare questo mondo.
Per la prima volta, non provò pietà, ma una sorta di ansia, una paura irrazionale. Non era più una donna; era diventata una bestia mostruosa. “Per oggi basta”, disse all’improvviso, chiudendo il taccuino. “Il freddo pungente non la ucciderà abbastanza in fretta. Prendetela.
Domani cercheremo di riscaldarla con il contatto umano”. Era il modo più deviante.
Usando il calore corporeo di un altro prigioniero per riscaldare la vittima, trasformarono l’abbraccio in una procedura medica forzata. I medici sollevarono la statua di Lena. Mentre la sollevavano, uno di loro scivolò sul ghiaccio. Il corpo rigido di Lena colpì il suolo.
Un forte schianto echeggiò, come un ramoscello secco che si spezza. Era il braccio sinistro di Lena. L’osso, indebolito dal freddo pungente, si era appena rotto.
Lena non urlò. Non batté nemmeno ciglio. Fissò il cielo. Nella sua mente intorpidita, osservò semplicemente: “Il braccio è rotto, non importa. Una pietra non sente nulla”. La riportarono in baracca e la gettarono sulla paglia come un sacco di macerie. Katya, la donna russa, era lì.
Vide il braccio storto, l’angolazione impossibile del gomito. Vide la pelle pallida.
Si avvicinò, con le lacrime agli occhi, pronta a riprendere a guardare, a offrirle il suo calore. Ma questa volta, quando Katya toccò Lena, ritrasse bruscamente la mano. Lena era così fredda che bruciava al tatto. Si era trasformata in un blocco di ghiaccio vivo.
Lentamente, Lena voltò la testa verso Katya.
Le sue labbra blu si dischiusero, non per gemere, non per implorare aiuto. Una voce roca, come se provenisse dall’oltretomba, le sfuggì dalla gola. “Non piangere, Katya.” La donna russa la guardò inorridita. “Lena, non piangere”, ripeté Lena. “Il freddo è uno scudo. Non può più farmi male.”
“Niente può più farmi male.” Aveva trasceso il dolore. Aveva ceduto la sua umanità alla neve, diventando un’arma. Sapeva che il dottore sarebbe tornato. Sapeva che ci avrebbe riprovato. Ma sapeva anche di aver perso. Lui avrebbe potuto spezzarle il corpo, congelarla…





